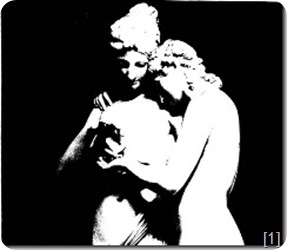Le fiabe, I simboli possono avere molte interpretazioni. Ne abbiamo raccolte alcune per dare al lettore la possibilità di vedere quanto diverse possano essere. Pensiamo che non si tratta di trovare quella più giusta, ma, forse, quella migliore, quella, o quelle che possono essere più utili per una maggiore comprensione di questa straordinaria storia.
.:.
Qui di seguito, perciò, tenteremo di fornire una nostra chiave di lettura, alla luce della filosofia platonica della quale Apuleio era seguace ed autorevole esponente.
L’allegoria assume connotati esplicitamente platonici proprio nella favola di Amore e Psiche, dove i nomi stessi dei protagonisti non possono non evocare alla mente la teoria dell’eros platonico, così come la troviamo espressa nella triade Fedone - Simposio - Fedro. D'altra parte la vicenda di Psiche rispecchia molto da vicino quella di Lucio, per cui si direbbe che la funzione della novella di Amore e Psiche - non a caso situata in posizione centrale nel romanzo - sia appunto quella di esplicitare in modo quasi didascalico, nella microstruttura della favola, il senso della macrostruttura che la include.
Ciò su cui ci pare indispensabile riflettere è il tipo di errore per cui cade l’anima.
Si tratta, come è noto, di un peccato di curiositas. Ma che cosa sia e che cosa rappresenti esattamente la curiositas nell'universo filosofico di Apuleio non è chiaro. Alcuni critici ritengono che essa venga valutata in modo positivo da Apuleio, quasi fosse per lui il tratto distintivo dell’intelligenza (salvo poi, dopo avergli attribuito questa opinione, tacciarlo di superficialità e frivolezza). A noi sembra, alla luce dell'esito di entrambe le vicende (la trasformazione magica per Lucio, le vista delle sembianze dello sposo divino per Psiche), che la valutazione non possa che essere negativa. In ogni caso, il significato dell’esperienza adombrata nelle Metamorfosi debba essere valutato con maggiore attenzione. Avanziamo a questo punto qualche ipotesi.
Apuleio, come già Euripide in un'opera altrettanto discussa ed enigmatica, le Baccanti, sembrerebbe contrapporre, nel suo romanzo, due modalità opposte del conoscere:
1) la Curiositas
(che in Euripide è designata con il termine sophòn), che si illude di poter arrivare alla decifrazione razionale dell’Essere attraverso l’osservazione delle forme dell’Apparenza (l’“abbandono al mondo”), dei fenomeni (etimologicamente “ciò che appare”) o dei segni in essa impressi.
Si pensi alla definizione che il filosofo Heidegger dà della curiosità: “ciò che preme a questo tipo di visione non è la comprensione o il rapporto genuino con la verità, ma unicamente le possibilità derivanti dall’abbandono al mondo. [...] La curiosità non ha nulla a che fare con la considerazione dell’ente pieno di meraviglia, con il qaumazein; non la interessa lo stupore davanti a ciò che non si comprende, perché essa cerca, sì, di sapere, ma unicamente per poter aver saputo” (Sein und Zeit, Halle 1927).
La curiosità, l'attitudine intellettuale di chi vuole sapere per il gusto di sapere, è quindi, sì, indizio di intelligenza, ma di un'intelligenza superficiale, presuntuosa e per molti versi infantile. E' questa l’illusione della scienza, ma anche quella dell'alchimia e della magia, la stessa di Apuleio prima della conversione; essa si rivela, a giudicare dalle vicende di Lucio e di Psiche, suprema stoltezza: la multiforme varietà delle cose né può essere realmente conosciuta nella sua essenza, né può condurre alla conoscenza di ciò che veramente è al di là delle apparenze e conferisce loro significato. La curiosità, si direbbe, è una modalità del conoscere che si addice ad un bambino, ma che in un adulto può essere rivelatrice di un'immaturità di fondo. L'adulto curioso è spesso un bambino intelligente che si rifiuta di crescere. Sennonché l'anima, in prospettiva platonica, ha un percorso di maturazione da compiere, deve crescere; e la presenza della curiositas, che continuamente distrae l'uomo dalla ricerca interiore spostando la sua attenzione su oggetti esterni, diventa ad un certo punto un ostacolo insormontabile. Accade allora un evento traumatico che costringe l'uomo a rendersi conto dell'inefficacia di questa modalità conoscitiva e a cercare altri mezzi di salvezza.
2) la Rivelazione (che in Euripide è designata con il termine sophìa): l’uomo, una volta caduto, deve passare attraverso l’inferno dell’abiezione morale e della disperazione, per arrivare a conoscere fino in fondo la nullità delle risorse intellettuali umane: solo a questo punto potrà intervenire la Grazia divina (Amore nella favola, Iside nella storia principale) a portare la salvezza attraverso la conversione. Si tratta di un percorso adombrato in numerose altre opere della letteratura mondiale: basti pensare alla Divina Commedia ed alle Confessioni di Sant'Agostino (non a caso grande estimatore del romanzo apuleiano).
A proposito delle Baccanti di Euripide ci si è spesso domandati se la contrapposizione tra le due modalità del conoscere adombri una "conversione" dell'autore dal razionalismo alla fede; a noi questo non solo non sembra verosimile, ma ci pare antitetico rispetto alle reali intenzioni dell'autore: egli infatti, a nostro parere, resta fino alla fine un appassionato difensore della fragile arma della razionalità (il Lògos) contro il disordine distruttivo dell'irrazionale - di cui è aspetto il fanatismo religioso -, pur nella dolorosa consapevolezza dell'inevitabile prevalere di quest'ultimo. Nel caso di Apuleio il senso della contrapposizione appare diverso, anche se, data la natura composita dell'esperienza filosofico-religiosa dell'autore, occorre cautela nel formulare giudizi. Quale che sia il senso esatto dell'esperienza, è da notare un particolare: nella novella di Amore e Psiche, l'Anima è già amata dal Dio fin dall’inizio (cioè è già salva), ma non lo sa: dubita, diffida, tradisce.
Questo elemento è squisitamente platonico e riconduce alla teoria della reminiscenza (si veda soprattutto il Menone): secondo Platone l'anima è già immortale, ma l'estrema ignoranza e confusione in cui è precipitata piombando nella materia l'ha immersa nell'oblio; non ricordando più chi è, vuole sapere ciò che in realtà non conta nulla, vuole vedere,sperimentare, indagare tà physikà, immergendosi nelle illusioni della materia ed allontanandosi così sempre più dalla sua originaria condizione immortale. Per poter essere di nuovo salva, dovrà arrivare alla conoscenza per una via completamente diversa: un percorso di sofferenza e di progressivo smantellamento delle illusioni, il cui esito finale è il buio della disperazione (la stessa cui conduce la "vita estetica" di Kierkegaard); solo a questo punto può finalmente verificarsi l'evento rivelatore: solo nel buio può rendersi visibile la tenue fiammella della reminiscenza - la sola conoscenza veramente possibile -, che accende nell'anima il ricordo di ciò che era in origine, e con esso il desiderio dell'immortalità.
Tuttavia, sebbene l'intervento della Grazia divina appaia fondamentale, non di fede - nel senso cristiano del termine - si tratta, ma di qualcosa di diverso. Non si tratta di credere: si tratta di capire. Apuleio, a nostro giudizio, non intende affatto la conversione come adesione acritica ad un dogma religioso, ma semmai come conquista della salvezza attraverso un percorso conoscitivo individuale profondo: una vera e propria gnòsi.
Troveremo più tardi in atto questa contrapposizione nella secolare e sanguinosa lotta della Chiesa cattolica contro le multiformi eresie di derivazione gnostica, che rifiutano ogni dogma, non attribuiscono alcun valore alla fede ed alla mediazione delle istituzioni ecclesiastiche e ritengono che la salvezza sia una conquista strettamente individuale, che si attua attraverso la conoscenza (in greco gnòsis, appunto).
François Gerard, 1798
LINK ALTRE INTERPRETAZIONI: - Filosofiche: http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/amorepsiche/interpretazioni/filosofica.html
- Folkloriche: http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/amorepsiche/folkloric/funznarr.html
- Junghiane: http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/amorepsiche/psicanalisi/interprpsican.html
____________________________________________________
Riepilogo:
1 - Amore e Psiche [1] La Fiaba
2 - Amore e Psiche [2] Il Significato del Mito (1) Eros, le Fasi, le Prove
3 - Amore e Psiche [3] Il Significato del Mito (2) I Misteri di Iside
4 - Amore e Psiche [4] Il Significato del Mito (3) La Psicologia
5 - Amore e Psiche [5] Il Significato del Mito (4) Interpretazioni varie